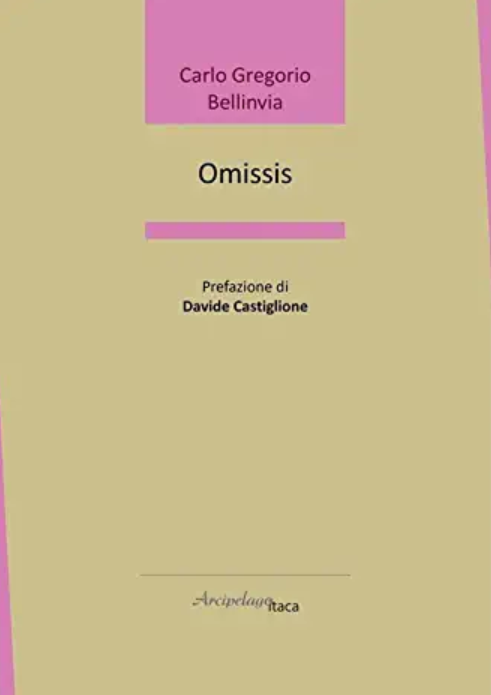Nota di lettura a Omissis di Carlo Gregorio Bellinvia
Pramāṇa è parola sanscrita indicante, collettivamente, i mezzi di conoscenza codificati dall’epistemologia classica indiana, ovvero: percezione, inferenza, analogia e testimonianza verbale.
La percezione, mezzo eccellente, nasce dal contatto tra i sensi e l’oggetto e, semplificando, può distinguersi in due fasi: nella prima essa non è esprimibile in parole, mentre nella seconda vede attivarsi la concettualizzazione. L’inferenza (di nuovo semplificando assai) è l’accertamento di una verità mediante un ragionamento sillogistico, ragionamento di cui porto qui il più celebre esempio, a cinque membri:
- ipotesi (oggetto della dimostrazione): “sulla montagna c’è del fuoco”;
- ragione logica: “poiché sulla montagna c’è del fumo”;
- esempio: “e qualsiasi cosa sia dotata di fumo è anche dotata di fuoco, come una cucina”;
- applicazione: “come la cucina, anche la montagna è dotata di fumo”;
- conclusione: “dunque sulla montagna c’è del fuoco”.
L’analogia è “quel mezzo che porta alla conoscenza di un oggetto in virtù della sua somiglianza con un altro oggetto comunemente noto”[1]. La testimonianza verbale, infine, è quella parola di conoscenza che proviene da una fonte autorevole.
Perché questa premessa? Perché sin dalla prima lettura dell’opera di Bellinvia, è stata proprio la parola pramāṇa (mi si perdoni l’“esotismo”, ma questa è la mia formazione/deformazione) a risuonarmi in testa
Cerco di spiegarmi.
La prima, notevole, sezione di Omissis s’intitola Dubbi grammaticali e ha come oggetto-espediente le parti del discorso (nome, pronome, verbo, aggettivo, articolo, preposizione, congiunzione e avverbio). Il testo si apre dunque su una direttrice linguistica, strutturale, conoscitiva, che, sin dal titolo, è messa in dubbio del codice e delle sue possibilità di “dire” l’esistente e le relazioni che in esso sorgono, come nei versi seguenti che mi hanno ricordato un bellissimo passo di Felice Cimatti: “(…) Perché entrare nel linguaggio significa entrare nella morte. Chi riceve un nome si sente mortale o morente, proprio perché il nome vorrebbe salvarlo, chiamarlo e assicurargli la sopravvivenza. Ogni nome è un presentimento del lutto. C’è un io e prima o poi cesserà di esserci”[2]:
Ma, sai, un nome alla fine
è soltanto un manico
con cui si dovrebbe
poter afferrare al bisogno
il tuo viso, che ora torna nel nulla
tra i ricambi di iddio,
per cui ti do un nome
Le parole sembrano vacillare di fronte allo straniamento provocato dalle cose immediatamente percepite (la smorfia terribile del bucato, il vimini di un uccello), sono inette quanto alla creazione di un dialogo con gli altri (sono stato un minorenne/fuori di casa e dalle frasi difficili/da connettere, per questo tiravo/pietre verso le persone/per aprire e dimostrar loro uno spazio maggiore, migliore).
Il discorso è fatto di primizie immangiabili, e dunque non è fruibile.
L’imprinting genitoriale stesso, la sua discorsività, viene “rinegoziata” ante-nascita, in versi che sembrano quasi ispirati da un novello e profano Bardo Tödöl[3]:
(…) a voi madre,
a voi padre, ai miei due autori
io chiedo però respiro, prego
di variare le parti del discorso.
Ridiscendiamo d’accordo
all’altezza del bacino,
come in occasione
del mio primo
intero. Intervenire lì.
Cercherò di essere
più di compagnia
già nella luna di miele,
in qualche modo
precedermi durante la vostra
prima notte
La faccenda del conoscibile e dicibile (come del non conoscibile e non dicibile, se l’omissis del titolo – l’omissione – può riferirsi non solo al non necessario o al volutamente ignorato, ma anche a ciò che costitutivamente resta per noi inattingibile), si amplifica nella seconda sezione del testo: Sillogismi dell’amore perso, dove l’amore, appunto, l’irrazionale per eccellenza, è sussunto provocatoriamente in una forma argomentativa sghemba, allucinata; una specie di stream of consciousness imbrigliato in una consequenzialità il-logica o una serie di libere associazioni travestite da ragionamento:
- un vassoio d’argento è splendente
- il mare è splendente
- le liquirizie Amarelli sono nere
- gli sguardi hanno il colore degli occhi
- i tuoi occhi sono neri
- i denti sono bianchi
- certe pietre sono bianche.
Versi dotati di una “fortissima sensibilità analogica”, come sottolinea Davide Castiglione nella sua corposa, approfondita prefazione, “formalismo istintivo, viscerale”, “inventività sintattica”:
(…) Prova
a riparare lampadine, richiedono attenzione
come inizi di bambini. Lasciata
l’esperienza della luce, quelli
pendono verso una prima forma,
dopo tutta la gavetta della loro trasparenza.
Non vi è alcuna conclusione razionale: il sillogismo è uno strumento disattivato e le cose dell’amore sono ciò che fallimentarmente si tenta di richiamare all’ordine, al dovere, salvo poi apostrofarle nell’animismo di una preghiera-incantesimo:
(…) Cose, doni, regali di lei,
io vi prego, bollite nel vostro sangue
freddo, abbiate un’ombra, e basta.
I vostri passati miraggi
fanno solo male, non sono
più animati davvero
Il mondo che magicamente si animava nell’incantamento amoroso (le sedie che si svegliavano con l’amata, i tappeti che si mettevano seduti, le finestre che spalancavano i loro occhi, in quel celebre testo di Hikmet) vanno depotenziate, così come è stato depotenziato il ragionamento.
La terza e ultima sezione si intitola Trenta mandate di chiave, e in essa si esprime in pieno “la matrice autobiografica (e traumatica) dell’ispirazione di Bellinvia”, “il senso di colpa del sopravvissuto” (D. Castiglione). Le trenta mandate non sono che trenta anagrammi della parola “sacro”; tutti anagrammi imperfetti, tranne uno, il XXV: sarco, titolo del potente testo incentrato sull’esperienza ospedaliera e sulla sopravvivenza vissuta come colpa:
(…) L’intervento
fu nero e vuoto, volò
a quote immense. Allora
il diritto-dovere del bianco
smise di demolire-costruire,
e atterrai nell’unità di un vaso
da quattro girasoli falsi,
con il grigio negli occhi.
Eccolo, lo stato del guarito.
Mi restituirono tutto, persi tutto.
Nāmarūpa è un’altra parola sanscrita, un composto. Significa, letteralmente, “nome e forma” e ha finito per indicare l’individualità psicofisica.
Per molte tradizioni, il nome è la cosa stessa.
Nella sezione finale, dopo il precedente corpo a corpo con la parola (“la sperimentazione inquieta e vigile, proteiforme”, D. Castiglione), la grammatica (quella stessa grammatica degli inizi dubitanti) si fa corpo:
quando il dittongo
o lo iato erano per lei
tosse grassa
o secca
ed è nel corpo che forse si annida davvero la sacertà terribile di ogni scrittura, quella testimonianza incarnata che è sempre autorevole, sempre fededegna. (Laura Liberale)
*
[1] Nyāyasūtra, I, 1, 6 (in R. Torella, Il pensiero dell’India, Carocci, Roma 2008, p. 37).
[2] F. Cimatti, Filosofia dell’animalità, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 89.
[3] “In questo istante tu immaginerai il padre e la madre carnalmente congiunti; ma così vedendo ricordati che non devi entrare fra i due. Medita su quell’uomo e su quella donna come se fossero il tuo maestro e la sua paredra e così venerali, porgendo loro offerte mentali (…)” (Il libro tibetano dei morti, a cura di G. Tucci, Utet, Torino 2004, prima edizione 1972, p. 170).