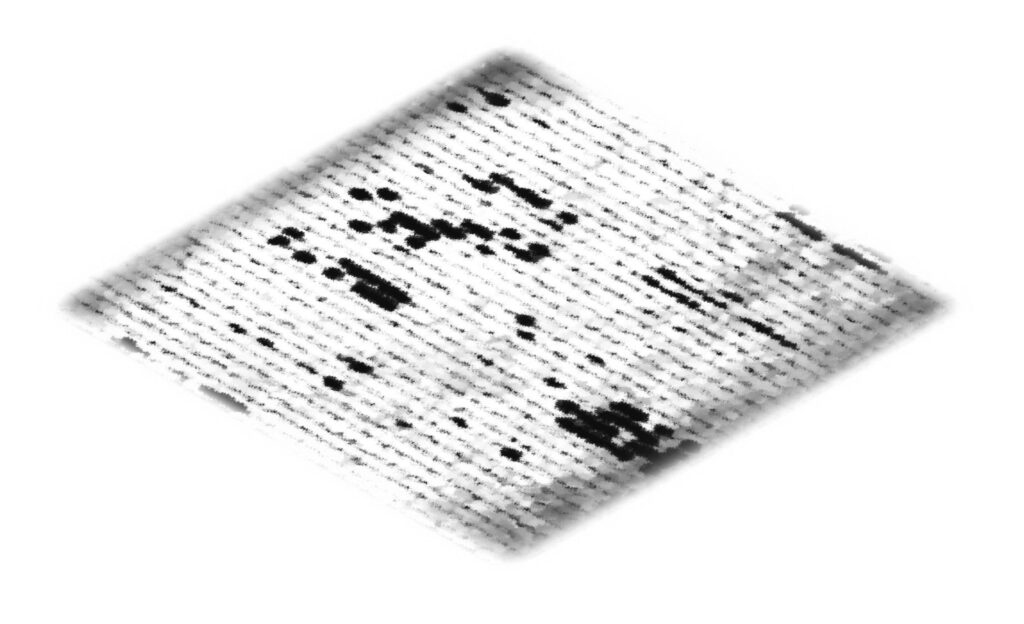Enzo Campi
Circuiti e cortocircuiti nel cronotopo del linguaggio
a Gilles e Jacques
Ipotesi e considerazioni sulle poetiche degli autori
che hanno ricevuto i Premi Speciali del Presidente delle Giurie
nella VII Edizione del Premio Bologna in Lettere:
Giorgiomaria Cornelio, Michela Gorini, Paola Nasti
Vanna Carlucci, Laura Cingolani, Davide Castiglione
Gianpaolo Mastropasqua, Alice Diacono
Ci troviamo in una sorta di limbo, in uno spazio, o meglio in una frattura tra due diverse temporalità, quella delle deposizioni (2020) e quella delle dissoluzioni (2021), che rappresentano le parole-chiave dell’ultima edizione del Festival Bologna in Lettere e della nuova edizione in via di costruzione. Se la deposizione è qualcosa che cade, ebbene quel qualcosa nel momento in cui incontra o si scontra con una superficie potrebbe anche dissolversi. Ecco quindi la dissoluzione, ovvero il senso della perdita o meglio ancora dell’evanescenza in cui fluttuano lo spazio e la spazializzazione dei significanti. È decisamente significativo che lo spazio e la fluttuazione rinviino al tempo e che il senso della perdita venga rappresentato o drammatizzato attraverso l’immagine dell’evanescenza. Questa immagine è una figura che innestandosi nello spazio-tempo crea un movimento, rilascia energia, mette in moto una macchina che produce innesti, flussi e interruzioni. Questa macchina si chiama scrittura, e la scrittura (un certo tipo di scrittura) – almeno idealmente – si rende succube della macchinazione che l’autore ordisce contro di lei. Ma perché parliamo di macchinazione? E in che cosa consiste questa macchinazione? In linea generale (ma le pre-disposizioni variano da autore ad autore) la macchinazione messa in campo dai praticanti della scrittura consiste nella creazione di una serie di figure e/o immagini che consentano di eludere l’immediatezza del messaggio e di costruire una struttura (meglio se instabile o cedevole) che possa permettere al fruitore un approccio attivo, pensante, costruttivo e non meramente contemplativo. Naturalmente la proposizione è reversibile: può accadere che sia la scrittura a ordire una macchinazione nei confronti dell’autore, rendendosi – sebbene a tratti e per parti (partizioni) – autonoma, fuorviando cioè le reali intenzioni dell’autore e incanalandosi verso direzioni impreviste e, per così dire, pervertite, sovvertite, ribaltate, secondo una delle lezioni di Carmelo Bene per cui si viene detti dal proprio dire e si viene scritti dalla propria scrittura. Si tratterebbe di precipitare, volutamente, in un sistema binario formato da un archi-phoné e da un’archi-scrittura, ovvero in un registro dove ci si apre a una infinita gamma di percezioni (e quindi – nella consequenzialità automatica della propagazione – anche di appercezioni), di partizioni, di variazioni cronotopiche, e via dicendo. Questo sistema binario dando voce alla scrittura (vedi più avanti quanto diremo di/su Castiglione) e rendendo leggibile la voce (vedi Cingolani) non può essere statico, ma dinamico. Deve produrre un movimento perché produce alterazioni. Ed è anche per questo che abbiamo accennato al movimento delle figure.
La figura può compiere un percorso? Può avere un tono? Può avere un ritmo?
Il movimento interno del testo (il movimento designato dalle figure) non può mai essere assoluto. Se fosse assoluto, e quindi compiuto in sé, non avrebbe bisogno di muoversi. Per questo il movimento, e quindi il rilascio di energia, dovrebbe sempre essere relativo, incompleto, interrotto, inesaustivo, dovrebbe cioè rinviare ad un’ulteriore possibilità, a una estensione del suo potenziale o, se preferite, dovrebbe far scendere in campo una sorta di volontà di potenza, non solo in senso propriamente nietzscheano, ma anche e soprattutto in senso desiderante, ovvero per favorire una sorta di inesauribilità di tutti i punti dell’ordine del discorso che conferiscono mobilità. Se ci concedete una breve digressione, vorremmo ricordare quei punti che Sini definiva “ubiqui” (Cfr. Etica della scrittura, Mimesis, 2009), dove al binario della provenienza e della destinazione si affianca il binario della presenza e della successione. È un po’ quello che accade nella scrittura di Cornelio: una successione di punti, la cui presenza si indirizza verso la sua stessa provenienza. Parafrasando lo stesso Sini, si potrebbe dire che per Cornelio valga “l’universalità spirituale” di una voce “de-somatizzata e trascritta”. Se ci fosse un tracciato grafico, questi punti (ad ognuno di questi punti, come vedremo meglio in seguito, corrisponde una partizione) verrebbero rappresentati come dei picchi, come un improvviso innalzamento delle proprie capacità espositive. Questo innalzamento innestato in un tracciato non sarebbe altro che una figura, un’immagine volta a rappresentare una sorta di andamento del flusso scrittorio. Naturalmente, non è detto che l’andamento debba corrispondere a una sola e univoca andatura. Anzi le andature mutano i loro piani d’immanenza e di trascendenza a seconda dei passaggi da una partizione all’altra. Per semplificare ci tocca ridurre questa figura a un’immagine della coscienza e/o a un’immagine della sfera inconscia. Così potremmo stabilire una linea sulla quale sistematizzare la poesia in particolare e la scrittura in generale. Se la scrittura fosse la risultante dell’immagine o di una serie di immagini della coscienza, avremmo, per dirlo con Deleuze (Cfr, L’immagine-tempo, Einaudi, 2017), un fenomeno qualitativo e inesteso (una sorta di sistema genetico, con tutte le approssimazioni che tale definizione comporta). Se invece la scrittura fosse la risultante del movimento di quella serie di immagini, avremmo un fenomeno quantitativo e disteso (un sistema fluente e pulsante). La questione, se ce n’è, è che i due diversi fenomeni/sistemi non esistono separatamente. Anzi, dipendono uno dall’altro, nel senso che da un movimento potrebbe scaturire un’immagine e che un’immagine potrebbe creare un movimento. Deleuze si riferiva propriamente alla “crisi storica della psicologia”, ma è un concetto che non fatichiamo a traslare nei registri significanti di una scrittura psicologica e psicoanalitica, dove è proprio a partire da una crisi che si può creare una crasi, un sistema di criticità da conferire alla scrittura. Così facendo si potrebbe evidenziarne i punti di rottura o i nodi, per così dire, nevralgici. Se il conscio fosse il doppio dell’inconscio (la proposizione è naturalmente reversibile) allora potremmo avere – ricordando Deleuze e amplificandolo in termini estensivo-oppositivi – un altro immediato e automatico, mediato e costruito, simmetrico e giustapposto, asimmetrico e disperso, simultaneo e differito. Il tempo dell’altro dovrebbe adattarsi alla specifica partizione dello spazio su cui, in un dato momento, esercita la sua influenza. Il tempo è mutabile, così come l’alterità: l’automatismo di una immagine restituita da uno specchio non sempre viene riconosciuta come copia conforme dell’immediato, la costruzione di una struttura spazio-temporale deve fare i conti con una mediazione che includa le partizioni di entrambi i sistemi, l’affiancamento tra l’io e l’altro, per comodità di pensiero, si vorrebbe simmetrico, la dispersione (chiamatela anche dissoluzione, disconoscenza, spossessamento, se volete) deve essere asimmetrica per definizione, deve agire in gruppo sparso e in tutte le direzioni, il differimento si dà solo in un regime di simultaneità. Questo è quello che avviene (o che potrebbe avvenire, se si riuscisse a guardare la cosa con un occhio clinico, anche patologico se preferite) nelle poetiche, complesse e articolate, dei nostri autori dove la predisposizione ai cosiddetti circuiti maggiori diviene un vero e proprio cortocircuito linguistico e concettuale. A parte Gorini, che rappresenta il caso più evidente, in quanto professionista del settore e la cui scrittura evolutiva/involutiva somiglia sempre più a un’autoanalisi (ed è forse proprio per questo che sembra inconclusa, sospesa, aperta, sempre pronta a ospitare in sé le infinite possibilità del divenire), ci troviamo ad applicare questo fenomeno di dipendenza, anzi di interdipendenza tra il conscio e l’inconscio, a quasi tutti gli autori qui trattati. La produzione icastica, fortemente connotativa, mai statica, sempre dinamica, di Cornelio, dove la forza motrice è proprio una forza psichica o le figure di Cingolani che si muovono a piccoli passi come per marcare sul terreno il solco che rappresenterà la cornice del quadro in cui prenderà vita e forma non solo il testo ma, anche e soprattutto, la sua forma psico-somatica. E ancora, i piani d’immanenza (o di ciò che a livello inconscio potrebbe mimare l’immanenza) di Diacono e Castiglione, tra loro diametralmente diversi per esperienze esistenziali, ambientazioni architettoniche e stile espositivo. Le materie fluenti e soventemente pulsanti di Nasti che mettono in moto tutto un meccanismo di percezioni, sia coscienti, che incoscienti, sempre sensibili, talvolta immateriali (uno dei pregi della scrittura di Nasti è proprio quella di rendere la materia elettivamente immateriale), ma comunque conoscibili, quelle percezioni che contribuiscono a creare il suo mondo fenomenico e noumenico, evidenziando cioè quel dualismo competitivo tra il sensibile e l’intelligibile che rappresenta uno dei suoi punti di forza. Le zone anatomiche e le zone metafisiche (ovvero gli spazi e i tempi dove la narrazione si fissa per rigenerarsi) di Carlucci in cui il flusso si relaziona con se stesso nel double bind tra il conscio e l’inconscio, le nuove prospettive spazio-temporali che Mastropasqua genera, quasi implacabilmente, in un registro musicale da cui si dipana un linguaggio introspettivo composto da ripetizioni, variazioni e inversioni come se volesse riprodurre la complessità dell’inconscio. Tutte queste figure/immagini, che viaggiano proprio su quella linea che divide il conscio dall’inconscio, producono drammatizzazione, o meglio: una descrizione o un’invenzione drammatizzate attraverso l’espediente-poesia. La poesia è qui il dispositivo che fa funzionare la macchina dei significanti. Così facendo li rende funzionali. A cosa? È presto detto: all’ordine del discorso. Un ordine che si nutre e si cementa sul disordine interiore e sul caos esteriore. È questa un’espressione generalizzata che va contestualizzata e diversificata da autore ad autore. Ad esempio, il caos in Cornelio è sorgivo, si perde e si ritrova nella notte dei tempi, invece in Gorini il caos è atemporale, si sviluppa, per così dire, nel tempo della notte. Interpretando in chiave soggettivo-associativa alcuni concetti di Torop, ci tocca notare una diversità di fondo che consiste nel diverso trattamento del cronotopo, ovvero dello spazio-tempo: un cronotopo stilizzato in Cornelio, volto all’individuazione della forma come segno distintivo e al fissaggio del marchio stilistico; e un cronotopo compensatorio in Gorini, volto alla disseminazione dell’apologia di una tematica forte e della funzione psicologica afferente. Ma non è tutto, bisogna tener conto anche delle diverse temporalità applicate al linguaggio in senso analitico. A dire il vero c’è anche una costante; entrambi, per quanto interiormente luminanti (ci riferiamo non tanto alla luminanza ma alla radianza, ovvero alla quantità di energia emessa; nel nostro caso specifico: l’energia psichica correlata all’energia trasmessa dalla scrittura) sono tempi al nero. Semplificando e riducendo, consideriamo il linguaggio al bianco (evanescenza) e il linguaggio al nero (fissaggio) come le due macro-partizioni, ideali e idealizzate, dello spazio-tempo letterario. La luminosità è data dal bianco che accoglie il nero. Il bianco è il disponibile, il lasciato-disteso, l’inerte che chiede di essere trasformato in grave. È naturalmente pre-disposto a farsi raccogliere, riempire, colmare, ridefinire. Il nero, di contro, tende a moltiplicare le accezioni dell’evanescenza del bianco. Sarebbe oltremodo semplice individuare nella scrittura, una «zona d’ombra» nell’inchiostro e una «chiara luce» negli spazi bianchi, ma la questione deve involarsi verso altre accezioni che possano indirizzarci sia verso una bipolarità (non clinica, ma comunque patologica nell’uso e nell’abuso del mezzo letterario) di fondo, sia verso l’adozione di un sistema binario che alterna diverse soluzioni paradigmatiche che accomunano le poetiche degli autori qui trattati, sia dal punto di vista esistenziale che da quello psicologico. La luce al bianco della rivalsa contro le avversità e la precarietà (luce al nero) della vita quotidiana (Diacono); la doppia poetica del dono e del dolo (al bianco e al nero) nella contrapposizione e nella compenetrazione tra affetti e restituzioni (Nasti); l’impaginazione grafico-concettuale che alterna l’inchiostro nero su fondo bianco e l’inchiostro bianco su fondo nero (Mastropasqua); la zona d’ombra della poesia concreta, deformata e sovrapposta, alternata alla chiara luce della sua trasposizione lineare (Cingolani, riferita nello specifico a Mangio alberi e altre poesie); la zona al nero dell’impossibilità di creare un intero e un’univocità, una zona questa che però non rinuncia a incontrarsi e scontrarsi con una scala di grigi, e che pur ammettendo la sua molteplicità e lavorando su di essa sembra lanciarsi in una sorta di ritorno al nero (Castiglione); la doppia funzione dell’involucro che contiene il buio al suo interno e nella restituzione all’esterno viene investito dalla luce (Carlucci); l’atipica proprietà (la promessa di una incinerazione?) di quel fuoco (che è luce primigenia e sorgiva) che attraversa il corpo solido e compatto dell’elemento che lo genera: la terra, al cui interno dimora l’ombra o comunque un cuore al nero (Cornelio). Un nero che mentre per Cornelio si dà a tratti, si potrebbe dire per macchie che riempiono solo una parte dello spazio, per Gorini tende invece a tracimare, raggiunge il suo limite come se ogni spazio non fosse sufficiente a contenere il nero che lo invade. Gorini lavora sull’asfissia di un qualcosa che non basta, che non è sufficiente. Ma, attenzione, l’asfissia è areale, tenue, leggera, quasi impalpabile, volutamente impalpabile. Cornelio invece non pratica l’asfissia ma allo stesso modo veicola l’impalpabilità e la leggerezza. Se anche ci fosse una soma, un peso da rivendicare, l’esposizione del dettato si sviluppa, per così dire e per dirlo con le parole di Julia Kristeva, sul “rischio del pensare”, ovvero: per “fare uscire la comprensione di un testo dalla propria chiusura, per inserirla in un quadro più ampio, che includa al contempo la storia di altri testi e ottiche diverse (Cfr. Il rischio del pensare, Il Melangolo, 2006)”, sulla traccia fantasmatica di un soggetto che non sempre resiste all’avvento degli oggetti che lo definiscono e che quindi tendono a cancellarlo. Lavorare sulla cancellazione per far rinvenire il soggetto in superficie non è una manovra alla portata di tutti. C’è quindi una sorta di volontà di cancellazione nella poetica corneliana. Una cancellazione che il nostro autore fissa o sospende in bella vista e che Gorini invece rende palese, ad esempio, attraverso l’uso insistente delle parentesi quadre che si auto-eliminano proprio mostrandosi implacabilmente e pedissequamente. Se nel primo la cancellazione è votata alla continuità nella seconda invece sembra votata all’interruzione. In entrambi i casi si tratta di un’aggiunzione. Aggiungere per interrompere è un procedimento che Lacan forse avrebbe sintetizzato nella medaglia verbale dell’«intervallo che si ripete». Che cos’è l’intervallo che si ripete? Secondo Lacan “è la struttura più radicale della catena significante, è il luogo frequentato dalla metonimia, veicolo […] del desiderio (Cfr. Scritti, vol. II,1974-2002)”. Stiamo quindi ipotizzando, per la nostra autrice, una scrittura desiderante (come è desiderante, ma su registri e livelli decisamente diversi, la scrittura di Carlucci). E ciò, in prima battuta, potrebbe anche rispecchiare la realtà delle sue intenzioni. Ma se lo stesso Lacan precisa che “ad ogni modo, è sotto l’incidenza in cui in questo intervallo il soggetto prova che lo motiva qualcosa d’Altro che non gli effetti di senso con cui un discorso lo sollecita, ch’egli incontra effettivamente il desiderio dell’Altro, ancor prima di poterlo anche solo chiamare desiderio e meno ancora immaginarne l’oggetto (Scritti, cit.)”, allora ci toccherà correggere il tiro ipotizzando una scrittura pre-desiderante che se per Cornelio produce una spazializzazione del luogo ove collocare l’altro originario e sorgivo, sottoposto alla continuità del flusso e alla contiguità con le macule al nero che invadono le partizioni rivestendole di un alone insieme psichico e metafisico per quanto innestato in una complessità volta al superamento della metafisica, nella scrittura di Gorini invece si popola di figure che colmando lo spazio non fanno altro che dividerlo in partizioni interagenti. Potremmo avere quindi una partizione macchinica, ripetitiva, anche ossessiva se vogliamo, in cui si verifica la perdita d’identità, una partizione esclusivamente desiderante o pre-desiderante, per quanto non definibile negli oggetti e nei soggetti da cui il desiderio prende vita e forma, e una partizione, per così dire, post-concettuale che nasce dopo che il concetto si è manifestato in quanto tale, perché la mancanza si manifesta anche nell’impossibilità che il concetto si renda esaustivo. È il caso di Cingolani, ad esempio, in cui il concetto non arriva alla sua significazione ultima, perché viene esposto attraverso una riproposizione differenziata. In quest’ottica la ripetizione produce il rinvio della significazione. Cingolani gioca su questo dispositivo per arrivare a raccogliere gli scarti di una realtà, o di una irrealtà, sottoposte alla macchinicità delle piccole variazioni che investono il tessuto dell’ordine del discorso e che sono, quindi e in ultima istanza, destinate alla mutazione. Cingolani sembra rivestirsi di questo tessuto e ne fa la sua seconda pelle (poco più avanti ribadiremo il concetto, sebbene attraverso parametri diversi, per la scrittura di Carlucci) una pelle che si sovrappone alla prima creando una sorta di pellicola. Ci troviamo così ad assistere a un fenomeno di ispessimento della superficie somatica ma fortemente condizionata dalla profondità psichica. Quasi paradossalmente a questo ispessimento si contrappone la flebile, tenue, leggera ma insistente voglia di aprirsi un varco, di agire lo spazio penetrandolo. Fare lo spazio significa anche cercare un contatto con esso. Per avere un contatto bisogna toccare. E lo spazio risponde risuonando. Lo spazio di Cingolani non restituisce il gesto toccando a sua volta chi lo tocca, lo spazio risponde risuonando. È come se a ogni contatto corrispondesse un suono e una vibrazione. E allora fare lo spazio significa fare la musica dello spazio, disvelare la voce dello spazio. E le frequenze sono talmente alte o talmente basse che per udirle bisogna calarsi in uno stato percettivo, bisogna entrare nella crepa ove il suono rimbalza e si diffonde. Un’opera, per certi versi, musicale quindi, così come è musicale l’opera di Mastropasqua. La differenza è che la prima è osmoticamente musicale, nel senso che si arriva alla propagazione dei suoni e delle vibrazioni attraverso una serie di passaggi linguistici tra loro intercomunicanti, mentre l’altra è dichiaratamente e anamorficamente musicale, muove dalla musica, parte da essa per arrivare a creare le parole e la loro spazializzazione. Per chiarire ricorriamo nuovamente a Kristeva: “La musica nelle lettere, così come l’esprime Mallarmé, destabilizza la significazione del linguaggio e la rinnova radicandola nell’inconscio e nel corpo (Il rischio del pensare, cit. corsivo mio)”. In un certo senso anche Ologramma in la minore (che è l’ultima opera di Mastropasqua) è impegnata a fare lo spazio. Come avviene ciò? Dividendo lo spazio, ritagliando in esso delle partizioni, imprimendo nello spazio una serie di affreschi geometrici in cui le parole si accoppiano copulando tra loro. In ogni caso, entrambe le poetiche, oltre a essere intercomunicanti, sono interdipendenti: inducono lo spazio (inconscio) a dedurre e quindi mostrare la presenza di una temporalità (conscio) che possa verificare quello spazio attraverso il linguaggio.
Lo spazio di Castiglione è una sorta di fabbrica, un’officina, una fucina come quella di Vulcano dove si lavorava col fuoco per forgiare i metalli, ovvero gli elementi con cui erigere non tanto una dimora quanto un manufatto, un contenitore di segni e segnali, segni che rinviano a una possibilità di senso e segnali che indicano una possibile direzione in cui incanalare il senso. Da qui nasce spontanea la domanda: sono questi i doveri di una costruzione? Il fatto che Castiglione abbia scelto la parola “doveri” non è un caso, è una parola che implica una responsabilità di carattere generale (che vale cioè per tutta la sua produzione) e che lo stesso Castiglione concettualizza fino al limite estremo. La costruzione, forse, si riferisce propriamente al testo. Quindi siamo al cospetto di una sorta di vademecum per la costruzione ottimale e funzionale di un testo. Da qui la responsabilità. Però nelle cose della vita – al di là della dicotomia guerrafondaia tra il soggetto cosiddetto fisico e il soggetto differito come oggetto nelle pieghe del testo – è sempre tutto provvisorio, è sempre tutto ri-definibile. In poche parole ci sembra che Castiglione sia orientato verso una ri-semantizzazione della realtà. Ma l’autore non si impone dei “doveri” per sfuggire alla provvisorietà e alla ridefinizione, sembra quasi che talvolta voglia lasciare agli altri l’incombenza e il peso di un dovere o di una serie di doveri, limitandosi a elencare e indicare, a proporre dei nomi o delle nominazioni che possono anche non risultare noti e che quindi inducono a un’indagine ulteriore. In poche parole e col beneficio d’inventario: un palinsesto dei doveri e l’indicazione della strada da seguire. Se ci si dovesse poi perdersi in quella strada, poco male, sarebbe ininfluente, perché comunque ci sarebbe una liberazione di energia, e quindi la costruzione di un flusso. Proviamo a spiegarci meglio. Castiglione sembra operare secondo le norme di una sorta di archi-scrittura differenziale, ovvero di un dispositivo che gli permette di parlare della scrittura mentre essa si compie nel differimento poetico. E tutti quei passaggi che potrebbero sembrare così tanto analitici da rischiare la didascalia, in effetti si strutturano e vivono sotto questa luce. Per queste ragioni, forse, possiamo comprendere perché Castiglione si dichiari “un autore essenzialmente narrativo”. Ma noi crediamo che Castiglione potrebbe anche concedersi il lusso di parlare della storia della scrittura (sulla falsariga dell’archi-scrittura derridiana, proponendo cioè l’esistenza di un “contenuto della forma”) e proprio mentre scrive o allude a una storia della scrittura. Così facendo narrerebbe di quel dispositivo che gli permette tale operazione. Il discorso sarebbe lungo, nonché complicativo. Si tratterebbe di costruire una scala, o meglio una gradinata (per dilatare le significanze in orizzontale, perché è proprio questa la direzione dell’espansione della scrittura) e discenderla per gradi, partendo dall’estetica (forma, figura, segno) e finendo nell’etica (contenuto idealizzato). Del resto scrivere è sapersi leggere e al contempo farsi saper leggere. E ancora: non c’è nulla di più etico che parlare della scrittura che in quel momento si sta scrivendo. Non è un procedere all’interno-di-sé, né un vizio tautologico, è bensì un procedimento formale in cui si mette in scena il contenuto di quella forma che si compie strada facendo. Certo, non sempre è così perché le idee non sono univoche e sono rivalutabili. In tale ottica anche la logica e la messa in carta della logica divengono rivalutabili e ridefinibili. Da qui la ri-semantizzazione di cui prima.
Avevamo accennato alle similitudini tra Castiglione e Diacono. Come afferma Berardi, in sede di prefazione a Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento, relativamente al flusso scrittorio di Alice Diacono si può pensare a una poesia in forma di prosa e contemporaneamente a una prosa in forma di poesia. Al di là della poesia e della prosa, i cui confini, oggi come oggi, sono sempre più labili e forse addirittura irrilevanti, ciò che conta è proprio la forma, una forma diretta, colloquiale, che rischia soventemente l’invettiva e che individua sempre il suo destinatario. Così Diacono si rivela sempre sul pezzo, le sue partizioni sono in realtà macro-partizioni perché indagano una vita che scorre, che tenta di riqualificarsi, che interrompe il suo fluire per soffermarsi sugli ostacoli che incontra e con cui si scontra, ma non per decretare l’impossibilità di scavalcarli o di aggirarli. Si sofferma sugli ostacoli per cantarli, per descriverli, per drammatizzarli, per filtrarli a suo favore, per permettere cioè a quegli ostacoli di divenire l’input per una loro esistenza ulteriore. L’ostacolo, l’incidente di percorso, il peso delle cose, le fatiche della vita, la morte che di tanto in tanto investe la vita, i semplici (si fa per dire) gesti quotidiani, tutte queste incombenze che investono la sfera inconscia incidendo implacabilmente sulla sfera conscia vengono prese a piene mani dalla nostra autrice e vengono deposte sulla carta, da qui il protrarsi della loro esistenza e del loro peso psico-esistenziale.
Quando Nasti, in una sola terzina (“soggetto rima con affetto/ essere affetti è tutto/ questo subire tagli”), restituisce l’affezione all’affetto, crea una catena patemica, non tanto simbolica, ma concettualmente necessaria, quasi indispensabile per creare un ordine del discorso che può fare a meno di essere o risultare eccedente, ma che non può liberarsi delle passioni. In poche parole “questo subire tagli” è l’azione (affezione) che l’affetto riversa sul soggetto, per quanto la pre-disposizione a comporre figure prediliga l’oggetto al soggetto. L’affezione ha una duplice valenza, può designare infatti una sorta di dissesto permanente, ma al contempo caratterizza la venuta dell’immagine del testo. La poesia è impura, doppia, neutra, ambigua, talvolta perfino asessuata. Non esiste una poesia esclusivamente maschile o una poesia esclusivamente femminile se non per generalizzazioni di comodo. La poetica di Nasti rispecchia questo assioma neutralizzando canoni e stereotipi, soggetti e oggetti facendo scivolare il senso e i sensi attraverso segni e segnali che potrebbero configurare una sorta di semiotica delle passioni. C’è giustezza nello stile adottato da questa autrice, una giustezza che, scusate l’allitterazione, rende giustizia alla scrittura.
Le due tipologie di carne, intese come corpo proprio e corpo d’altri, rappresentano il leit motiv principale degli Involucri di Carlucci. Queste due tipologie rinviano almeno ad altre due opposizioni: mondo proprio/mondo altrui e linguaggio proprio/linguaggio altrui. Inutile sottolineare la moltiplicazione, anche ontologica se vogliamo, dell’involucro. In chiave prettamente linguistica ci troviamo a fare i conti con almeno due lingue, quella dell’io e quella dell’alterità. Essendo entrambe contenute nell’involucro, si potrebbe parlare di un dispositivo di inglobamento al cui interno, per restare in chiave di temporalità, dovremmo distinguere almeno l’istante dalla durata, ovvero l’intensità condensata dall’intensità estesa. Nell’intensità condensata il gesto di cogliere l’istante se da un lato espone la carne, dall’altro lato sembra come neutralizzarla rispetto al tempo che è già passato ed è già proteso verso il suo prolungamento. Tuttavia il gesto resiste alla sua evoluzione imprimendo un segno di cui la chōra si fa depositaria, e che potremmo sintetizzare nel “trattenere una caduta”, la caduta in cui l’istante, fissandosi, entra a far parte, per così dire, della memoria storica del fondo-di-sé, ovvero di una delle partizioni in cui è suddivisa la chōra. Mentre nell’intensità estesa niente ci sembra più calzante e significativo che estrapolare un passaggio dalla prefazione di Tiziana Cera Rosco per comprendere ciò che accade: “un tentativo di accoppiamento col corpo del mondo”. E questi sono solo i gesti inaugurali della costituzione di una serie, a cui si aggiungerebbero almeno altre due macro-categorie: la carne psichica del corpo proprio e la carne psichica del corpo d’altri, e ancora: le ossa che permettono alla carne di avere una struttura, il cervello che è a sua volta un involucro, in quanto contenitore e veicolatore della carne psichica, e via dicendo. “C’è qualcosa oltre la pelle,/ dentro gli organi viventi,/ il sangue e le ossa:/ sai che da questo interno ci passa l’aria”; leggendo questa strofa dovremmo presupporre l’esistenza di una intercapedine. In questa intercapedine ipotizzeremo il luogo della scrittura, una scrittura schiacciata, compressa tra la pelle (il freddo, l’impuronero) e gli organi (il caldo, il “purobianco”). L’antinomia freddo/caldo, tra le altre cose, rappresenta uno dei fili conduttori della poetica corneliana; si potrebbe osare anche una sovradeterminazione portando i due elementi al loro punto-limite e trasformandoli quindi nel glaciale e nell’ustionante. Comunque, è in una doppia ambivalenza freddo/caldo-nero/bianco che Carlucci sceglie l’esposizione più adatta per immortalare la figura. Il suo cruccio è, forse, quello di non poter trasmutare l’intercapedine in una figura. L’intercapedine (che potrebbe essere considerata, a tutti gli effetti, un cronotopo, vuoi solo perché la scrittura aggiungerebbe, automaticamente, una temporalità allo spazio) non è visibile, si può solo sentirla dentro di sé, è, come vedremo più avanti, quel vuoto-forma teorizzato da Nasti e praticizzato da Cingolani, è il “contenuto della forma” (archi-scrittura) che, per comodità, definiamo «vuoto». Ma questo vuoto, questo spazio secondo Carlucci è attraversato dall’aria. E quindi aggiungeremo un’accezione all’operazione di Cingolani, affermando che fare lo spazio significa anche assecondare l’aria di quell’intercapedine che raffredda il calore degli organi e riscalda la freddezza della pelle. Ed è così che Carlucci, giocando sull’ambivalenza di fondo degli elementi costitutivi della sua chōra, cade e trattiene la caduta, precipita “come precipitano gli involucri” e cerca “un nido” ove assestarsi, cerca di discostarsi dalla “separazione” ma poi ritorna a essa. Tutti questi fenomeni sono partoriti dalla carne psichica, ma se la carne e il corpo sono materie solide e se la scrittura fosse materia potremmo avere una scrittura materica statica e una scrittura materica dinamica. Entrambe sono, o dovrebbero essere, sensibili. Nella scrittura statica c’è comunque una liberazione di energia relativa alla formazione di parole, frasi, concetti rivolti all’esternazione del significato. Nella scrittura dinamica il movimento è diverso, più strutturato, sempre delocato, spostato. Si sposta, secondo la lezione deleuzeana, attraverso lo spostamento dei significanti (Gorini), si autoelimina rinvenendo solo nelle partizioni di cui è formato il tutto (Cornelio), si consegna all’affezione dello scambio tra l’invio di un segnale e l’eterno ritorno dell’invio al mittente (Nasti), si ricopre di una patina, di una membrana, tanto sottile quanto penetrabile, attraverso la quale illudersi di preservare un’integrità (Carlucci), si arieggia, si spazializza, crea altre fratture nella prima frattura, riempie, svuota, conferisce liquidità al concetto (Cingolani), lancia un grido politico di insoddisfazione designando e disegnando i tipi, le tipicizzazioni attraverso le quali il riconoscimento del fenomeno destabilizzante viene posto dinanzi al suo spaesamento (Diacono), si squadra e si inquadra in una partizione dello spazio, si rende prigioniero dello spazio ma al contempo libera lo spazio attraverso una fuga che si rende tangibile nella risonanza delle parole (Mastropasqua). In tutti i casi si tratta di fare i conti con la percezione, sia quella indotta dall’autore che quella recepita o fuorviata dal fruitore. Quando Nasti dice: “giace allo stesso tempo/ chiuso dentro/ chiuso fuori/ indecifrato” sembra quasi alludere agli Involucri di Carlucci dove l’ambivalenza dentro/fuori associata alla chiusura/apertura potrebbe rappresentare una delle chiavi di lettura dell’opera. Ma concentriamoci, solo per un attimo, sulla percezione.
In realtà, e a ben guardare, nelle poetiche dei nostri autori troviamo almeno quattro tipologie di percezione:
- una percezione istintuale, dovuta agli elementi che non trovando una collocazione definitiva tendono a spazializzarsi (Cornelio, Cingolani, Mastropasqua)
- una percezione cosciente, dovuta agli elementi che non solo trovano un luogo specifico ove radicarsi, ma lo abitano fino al limite estremo (Diacono, Castiglione)
- una percezione ambivalente, dove la restituzione dell’oggetto al soggetto, rigenerando le sue pulsioni, può anche essere definita affezione. Non l’affezione morbosa ma, in senso propriamente spinoziano, una sorta di ocursus, di «incontro/scontro» tra le prime due tipologie di percezione (Nasti, Carlucci)
- una percezione sensibile, in cui il flusso viene scandito attraverso accelerazioni e decelerazioni che cercano nella riconciliazione dei contrari il loro stato di vulnerabilità (Gorini)
Dalla percezione alla partizione il passo è breve, nonché obbligato. Vuoi solo perché non si può pretendere da un semplice fruitore una percezione totale e totalizzante, che sia cioè istintuale, cosciente, ambivalente e sensibile, una percezione che comprenda il tutto non curandosi delle parti che lo compongono. Per queste ragioni abbiamo pronunciato più volte il termine partizione, un termine che appartiene sia allo spazio che al tempo, sia alla sfera inconscia che a quella conscia.
Parliamo di partage quindi, che significa letteralmente partizione e che Derrida, rivolgendosi nello specifico a Nancy, estende alla partecipazione, alla spartizione, alla continuità e all’interruzione (Cfr. Toccare, Jean_Luc Nancy, Marietti, 2007). Anche se in realtà lo stiamo facendo fin dall’inizio, proviamo ad applicare questi quattro enunciati ai nostri autori. La partecipazione di Diacono che si presenta come protagonista delle sue storie e che quindi dirige dal centro la partizione del suo stesso spazio linguistico/esistenziale, la spartizione di Castiglione che attribuisce ai suoi personaggi un luogo (e quindi uno spazio, o meglio una parte di spazio) specifico dove agire o farsi agire, la continuità di Nasti che paradossalmente trova la sua significazione ultima e definitiva negli spazi bianchi, nei vuoti, nelle pause, negli intervalli in cui far sedimentare i concetti e le visioni, le interruzioni di Gorini che non esiteremo a definire esche, non tanto per catturare l’attenzione (questo è un bisogno tipico della narrativa più che della poesia) ma per far evolvere il concetto o, se preferite, una traccia di concetto su piani altri che sono quasi sempre simultanei al primo in un double bind che non si vergogna di mettere a nudo la sua ambivalenza di fondo, tutte queste «pre-disposizioni» (la disposizione potrebbe rappresentare il nostro quinto enunciato e la pre-disposizione rappresenterebbe quindi un’organizzazione delle partizioni, cosa questa da non trascurare nell’approccio alle scritture dei nostri autori), tutti questi tentativi di definire o di sfinire uno stile sono, a tutti gli effetti (ma anche con i loro difetti, talvolta addirittura ostentati come metodo per dipanare la matassa concettuale), dei partage, sono «divisioni-per-parti» che estendono la funzione linguistica, una divisione che nella scrittura di Cornelio sembra prediligere il fenomeno, o meglio la fenomenologia dell’attrazione, quasi magnetica, tra i vari frammenti che fluttuano nel suo personalissimo cronotopo linguistico, che nella scrittura di Carlucci, come già accennato, sfiora ripetutamente i vari concetti di chōra, una chōra che sembra esasperata dall’atto di far tracimare i suoi scarti, senza dimenticare che Nancy dichiarava che scarto e contatto si danno in un regime di simultaneità e che Carlucci traduce esemplarmente in un passaggio che è assolutamente dichiarativo in tal senso: “nell’abisso di uno squarcio/ io vedo la/ radice d’ogni vena” e che implica un contatto visivo pronto a trasmutarsi in un contatto fisico, che la scrittura di Castiglione, per restare nei registri nancyani, tende a toccare il limite, ovvero a toccare senza toccare, in quanto il limite è intoccabile. È percorribile ma non si può determinare la sua consistenza. Ma c’è di più, la fenomenologia di Castiglione, imponendosi un “dovere”, riconosce i limiti della sua “costruzione” ricorrendo proprio al partage, alla partizione e alla partecipazione dei vari elementi che contribuiscono alla formazione dell’ordine del discorso. Senza dimenticare la continuità, quasi esasperata, che Mastropasqua traduce nel dispositivo della ripetizione o, se preferite, della ripetizione del dispositivo che evoca una sorta di sublimazione che si estende oltre e sopra le righe. In senso anche propriamente letterale: le parole figurate (inscritte in una figura come a rappresentare una mise en abyme del linguaggio), oltre a creare una partizione dello spazio si protendono verso la creazione di uno spazio ulteriore e, per così dire, superiore dove ciò che conta è l’aspetto corale definito (marchiato a fuoco) dal contatto (e quindi dallo scarto) tra la musica e quel doppio movimento di incremento/decremento che permette alle sillabe di ogni singola parola di arrivare a una nuova e, oserei dire, pervertita accezione di partizione. Un discorso a parte meriterebbe la scrittura di Cingolani, il cui inedito Fare lo spazio ci fa precipitare, fin dal titolo, in una dimensione calzante ma complicativa, perché evidenzia la volontà, l’autodeterminazione di cercare lo spazio più adatto per farsi essa stessa spazio all’interno di un tempo che non si può definire se prima non si agisce in esso. Il “tempo è incalcolabile” (lo dice la stessa autrice), produce una dimensione di vuoto. E allora, forse, si tratta di farsi spazio nel vuoto, o meglio di divenire lo spazio del vuoto. E affermare “qui ho tolto tutto” significa: qui ho fatto spazio, qui ho creato uno spazio possibile/impossibile dove “cambiare percezione e armature/ per fare lo spazio/ per farlo perché// sia a misura di me”. L’ultimo verso fa scendere in campo la compatibilità con lo spazio. Cingolani, in realtà, si preoccupa di essere compatibile non tanto allo spazio che verrà, ma all’azione di fare uno spazio. È un work in progress in continua e perenne mutazione. Non c’è un fine o una fine: l’azione deve essere reiterata ad aeternum vuoi solo per rispettare le intenzioni del titolo. Uno spazio che Nasti, nell’opera ancora inedita Il libro degli affetti e delle restituzioni, sembra invece, almeno in prima istanza, voler castrare e insieme sezionare come a dare l’impressione di impedirne una crescita esponenziale. Un passaggio come “disporre creta a contenere spazio/ ritagliarlo” è indicativo in tal senso. Ma, a ben guardare, c’è anche una volontà di costruzione. Al di là della “creta” che, una volta plasmata e trattata, può assumere qualsiasi forma, poco più avanti, se leggiamo attentamente (“disegniamo le tracce/ modelli e chiodi per il pensiero/ col carbone e con l’acqua/ con cere colorate/ componiamo figura”) ci rendiamo conto di come la creazione di una “figura” (ovvero di un innesto nello spazio, di una partizione dello spazio) avvenga attraverso l’uso (o l’abuso) di svariati elementi. In questa apparente opposizione d’intenti (impedire la crescita/favorire la crescita) Nasti sembra evidenziare un’attenzione particolare non tanto allo spazio ma alle stratificazioni temporali che quello spazio nel suo doppio e oppositivo movimento fomenta nell’evoluzione dell’ordine del discorso. Questi elementi sono una parte degli oggetti sensibili che Nasti inserisce in un particolare dispositivo rivolto a far divenire sensibile il tempo in cui disperdere e disporre lo spazio. Non è un caso che nella scansione dell’opera, posponendo i termini del titolo, le “restituzioni” cadono sulla pagina prima degli “affetti”. Un po’ come a voler dire che il gesto di ritorno precede il gesto d’invio. Il divenire-sensibile dello spazio si nutre proprio di questo ribaltamento, di questa sovversione dell’ordine del discorso, mettendo a nudo l’idea che la consequenzialità logica non può condizionare la formazione di uno spazio dove, per dirlo con la stessa Nasti, sono le “reti di parole” e il “tornare agli elementi” i fattori precipui del discorso poetico. In definitiva, attraverso un punto d’osservazione più complessivo, ci si rende conto di come gli affetti rappresentino la resa e di come le restituzioni invece equivalgano all’azione. Quel “ritagliare” lo spazio nella partizione delle restituzioni genererà un’azione. Ma l’azione consiste anche nella “passione di arrendersi”, ovvero nella “passione/ degli affetti”. Tutto questo per certificare i due versi-chiave dell’opera: “che poi gli affetti/ sono restituzioni”. E allora, l’invio e il gesto di ritorno, forse, coincidono, convivono nello stesso spazio, abitano la stessa partizione, si fanno fautori della stessa temporalità. E quindi non sarebbe del tutto illecito pensare che la sovversione che ribalta la consequenzialità logica della scansione del discorso non sia altro che l’ennesimo gioco al massacro in cui è impegnata la poesia.
Quel famoso sistema di criticità, l’individuazione del punto di rottura, la ricerca dei nodi sono dispositivi di disconoscimento. Ma così facendo, operando cioè in funzione della ricerca di un diverso paradigma, si cade automaticamente e inevitabilmente in un sistema di riconoscimento. Quelle del riconoscimento, ma anche quelle dell’inquadramento in un canone, in uno stile, in una modalità di scrittura sono questioni che esistono da sempre e da cui risulta difficile liberarsi. Prendendo in prestito alcuni passaggi bergsoniani rivisitati da Deleuze (Cfr. L’immagine-tempo, cit.), proviamo ad individuare due categorie di riconoscimento che hanno a che fare, direttamente o indirettamente (a seconda del punto d’osservazione), con le percezioni e con le partizioni: il riconoscimento automatico e il riconoscimento attento. Il primo si basa sull’abitudine, è quasi rassicurante perché produce sì un prolungamento della percezione in base a un sistema associativo che ci permette di passare da un oggetto all’altro, da un’immagine all’altra, ma restando sempre sullo stesso piano percettivo (Diacono, e per certi versi, con qualche eccezione significativa, Castiglione e Cingolani). Il secondo consiste nel far ritorno all’oggetto per studiarlo, per estrarre le sue peculiarità, la sua impronta, il marchio che lo distingue su diversi piani percettivi. Abbiamo così da una parte una serie di oggetti disposti sullo stesso piano, e dall’altra parte un solo oggetto che trasla su diversi piani (Gorini, Cornelio). Se i piani dovessero interagire tra loro – ed è proprio quello che accade per le scritture di Cornelio e Gorini – allora dovremmo parlare anche di innesto, quel dispositivo, formale e sostanziale, che permette di combinare tra loro elementi eterogenei ma affiliati come a un ordine superiore che impone loro non di perdersi per ritrovarsi, ma di perdersi per arrivare alla perdita-ultima, quella del rinnovamento. Beninteso il rinnovamento non è essenzialmente un sinonimo del riconoscimento. Il riconoscimento pretende una genetica ben fissata in punti e linee che conducono verso una meta definita e definibile. Questo tipo di riconoscimento persegue obiettivi diversi proprio perché fomenta l’attenzione, necessita di studio, di un impegno particolare, sia per identificare l’oggetto che per classificare i piani.
Se i piani sono partizioni (spazi inconsci) allora sono gli oggetti a definire le temporalità consce di quegli spazi inconsci. È compito dell’autore disseminare tracce, indizi che possano far rinvenire in superficie un processo di questo tipo, al di là delle possibilità percettive di ogni singolo fruitore. Anche gli Involucri di Carlucci sono dei piani, o meglio una stratificazione di piani dove passa, dove agisce lo stesso oggetto. Qual è questo oggetto? È presto detto: il corpo. Ma il corpo viene generalmente inteso come soggetto. Come dobbiamo comportarci quando soggetto e oggetto coincidono in una stessa entità? Non abbiamo detto in una stessa unità perché la coincidenza, la compenetrazione tra soggetto e oggetto non forma necessariamente un’unità. Parliamo quindi di un’entità che incarna l’immobilità dell’oggetto e la mobilità del soggetto. Immobilità + mobilità = identità (scusate la forzatura anti-epistemologica, quasi derridiana, nell’attribuzione di una certezza basandosi su una coppia di contrari fisici che, solo apparentemente, si discostano dalla risultante psichica che viene loro attribuita). E allora quell’andare per piani potrebbe essere rivolto alla ricerca di un’identità di cui ricoprirsi, di cui rivestirsi. Ecco quindi l’involucro, non solo un contenitore, un deposito-di-sé-in-sé, ma anche una seconda pelle che ricopre la prima, una pellicola, magari trasparente, che mostra ciò che si era prima del trattamento e ciò che si diviene dopo il trattamento (secondo la regola, non scritta, che la scrittura deriva sempre da un «trattamento» dell’io su più piani percettivi). In poche parole, l’involucro aggiunge il piano dell’opacità all’oggetto originario, creando quindi un nuovo tipo di riconoscimento che non è né automatico, né attento perché fuorviato dalla pellicola, un riconoscimento doppio e simultaneo, sia qualitativo e inesteso che quantitativo e disteso e che si potrebbe definire come riconoscimento del rivestimento, un riconoscimento dove l’oggetto differito in soggetto si definisce contiguo a tutti i piani, sia a quelli concreti che a quelli astratti, sia a quelli derivanti dallo spazio inconscio che a quelli derivanti dal tempo conscio. Questo tipo di riconoscimento non attraversa ma si fissa. Ma, attenzione, il fissaggio può evidenziare anche una frattura o una serie di fratture che, a ben vedere, costellano la scrittura di Carlucci, per cui il riconoscimento del rivestimento potrebbe essere ribattezzato come riconoscimento dei sistemi di frattura, un po’ come dire che la funzione del rivestimento sia quella di ricoprire le fratture per camuffarle ma anche per evidenziarle. Se questo corpo è il soggetto-oggetto della scrittura, vuol dire che anche la scrittura deve calarsi in un regime ambivalente di opacità/trasparenza. Deve mostrare, o quantomeno deve lasciare intendere ciò che c’è sotto e dentro. È questa la funzione degli involucri? Non possiamo darlo per certo. Così come non possiamo dare per certo che le scritture di Nasti e Mastropasqua possano essere incluse in una di queste tipologie di riconoscimento. Ci toccherà quindi ipotizzare un quarto tipo di riconoscimento che potremmo definire riconoscimento icastico e che si fonda sulla composizione di figure. Una figura può contenere un solo oggetto o di contro essere la risultante di un insieme di oggetti. Le figure di Mastropasqua sono, in un certo senso, invadenti, decisamente estese, quasi gettate in pasto alla percezione. Pretendono di essere percepite in quanto tali, in quanto figure estreme, portate al limite, mentre le figure di Nasti sono nascoste, si lasciano intravedere, si estendono quasi timidamente. Si potrebbe parlare di una tessitura latente che diviene una partitura estesa solo a condizione della nullificazione della sua immediatezza, si conduce cioè verso una risoluzione che coincide con la sua nullificazione. Proviamo a chiarire: si nullifica perché non dice il fatto ma implica l’entrata in campo di un fenomeno che non si limita al solo cogitare ma mette in discussione il dato sensibile amplificando le sue possibilità d’esistenza. Il fatto che questa amplificazione coincida con il nascondimento non lede la sua portata e il suo spessore, ma anzi caratterizza indelebilmente le sue possibilità d’esistenza. L’esistenza di un cogito che si esprime attraverso la composizione di figure diviene così un effetto di linguaggio (naturalmente anche la cosiddetta invadenza di Mastropasqua rappresenta un effetto di linguaggio) il cui compito principale non sarebbe quello di moltiplicare la sua eco, ma di creare una linea tra eco e ego, una linea da calpestare e da cui farsi calpestare. Una eco congiunta all’ego che mette in scena (che toglie dalla scena dall’immediato ma che al contempo innesta sulla scena del divenire) una frattura differenziale. Resta beninteso che l’ego, nel nostro caso specifico, non deve essere inteso come eccedenza della presenza-di-sé-a-sé, anzi il suo compito sarebbe quello di creare una base che possa permettere la venuta-in-presenza dell’eco, di quella risonanza che ripete più volte il concetto per poi sparire. Per queste ragioni l’eco vive in funzione del raggiungimento di una posizione. Qual è questa posizione? È presto detto: la sparizione, il dissolvimento, la dissoluzione. È significativo che sia proprio la sparizione a cambiare i termini del dato di fatto per inaugurare il fenomeno. Ecco questo, ad esempio, è l’effetto di linguaggio della poetica nastiana. Ciò che sopravvive a questa sparizione, il cosiddetto fenomeno, prende il nome di figura. Non si tratta di una figura semantica ben precisa e delineata, ma di un qualcosa di sfuggente, quasi impalpabile che non impone la sua presenza: “l’affetto è la membrana/ di ciascun vuoto-forma, di tutto/ il sensibile, avvolto/ in membrana solubile”. Estrapoliamo da questa ultima citazione la parola-baule “vuoto-forma”. Ci sembra quasi una perfetta e calzante definizione del cronotopo, per così dire, assoluto di tutta la produzione cingoliana. E quindi, quasi senza rendercene conto, abbiamo elencato quattro tipologie di riconoscimento. Può essere possibile stabilire un regime di equivalenza con le quattro tipologie di percezione elencate poco più indietro? Ci teniamo a precisare che si tratta di percezioni doppie che, nella fattispecie, vengono ipotizzate sia nelle presunte intenzioni degli autori che nelle ricezioni dei fruitori. Non devono essere intese come dogmi inalterabili, anzi come un qualcosa di alterabile, sia altero che mutabile. Detto questo, crediamo che un’ulteriore indagine in tale ottica potrebbe richiedere sia la messa in campo di un cronotopo pluri-esteso, sia l’introduzione a un sistema di segni e a un palinsesto di figure. E inoltre bisognerebbe indagare il fenomeno secondo un’ulteriore suddivisione interna delle singole percezioni, ovvero attraverso il fissaggio, la fibrillazione, l’intermittenza, i circuiti chiusi o aperti, la velocità dell’apparizione, la persistenza dell’apparizione, e via dicendo. Cosa questa che non è fattibile in questo contesto. Per cui accontentiamoci, per il momento, di evidenziare un sistema, insieme combinatorio e differenziale, di supposta interagenza o di similitudine tra il riconoscimento automatico e la percezione istintuale, tra il riconoscimento attento e la percezione cosciente, tra il riconoscimento dei sistemi di frattura e la percezione sensibile, tra il riconoscimento icastico e la percezione ambivalente. Così facendo però ci troveremmo a ipotizzare per ciascuno dei nostri autori la predisposizione a farsi usare da più sistemi di riconoscimento e da più tipologie di percezione e a usarli a proprio piacimento per rendere più articolato l’ordine del discorso. Solo così un circuito può divenire un cortocircuito. Circuiti e cortocircuiti, riconoscimento e percezione, deposizioni e dissoluzioni, spazio e tempo, conscio e inconscio, zona d’ombra e chiara luce, fissaggio e spazializzazione, e gli altri double bind qui argomentati o solo accennati rappresentano una serie di sistemi binari.
Ma il sistema binario non è sempre pacifico (in sé) o pacificante (nella sua ricezione all’esterno), esso si costituisce spesso attraverso un duello tra due elementi o registri che viaggiano in parallelo all’interno di una cosa; e ancora: il sistema binario è generalmente (e deleuzeamente) dividuale, rappresenta ciò che non può essere né divisibile né indivisibile. E se, per forzatura fenomenologica o per semplice frattura concettuale, dovesse essere diviso (come una strada che improvvisamente si biforca) o dovesse essere riunito in una univocità, ciò avverrebbe solo a condizione della sua trasformazione in qualcosa d’altro. Così verrebbero a trasformarsi anche la natura del suo cronotopo e il linguaggio attraverso il quale esso si manifesta o si nasconde. In poche parole un sistema binario dividuale consisterebbe nel rivestire il linguaggio con la figura di una maschera, e il risultato sarebbe quello di una deformazione dei suoi tratti caratteristici e il conseguente spostamento del significante da un piano meramente linguistico a un piano semantico pluristrutturato. Questo accade a chi opera per composizioni e giustapposizioni di figure (statiche o dinamiche che siano), ed è un discorso riconducibile a quasi tutti gli autori che hanno, involontariamente, prestato le loro poetiche a questa opinabile disamina psico-filosofica sul rilascio di energia all’interno/esterno di un sistema di linguaggio innestato in un cronotopo idealizzato.
Se il movimento (che avviene sempre nello spazio o in una sua partizione, che avviene per lo spazio) si apre al tempo e penetra in esso, allora il tempo conterrà il movimento. Il tempo è una gabbia che contiene (pensate sia all’inglobamento che a un contenimento con un’ideale camicia di forza) il movimento, è la sua prigione. La poesia così sarebbe costretta a operare attraverso la creazione di temporalità temporanee, eterogenee, anche irreali o surreali se vogliamo. Una poesia che non sia atemporale o pluritemporale è una poesia statica. È morta in sé perché non è provvista di un punto di fuga. Per queste ragioni non dovrebbe esistere una poesia esclusivamente narrativa, perché la designazione di una temporalità ben precisa la renderebbe prigioniera. Con questo non vogliamo dire che la poesia debba essere, per forza di cose, anti-narrativa, ma che il suo status connotativo dovrebbe essere quello di un “oggetto complesso”, e il suo compito dovrebbe essere quello di innestare un sistema di criticità nell’ordine del discorso, pena il suo relegamento in una dimensione spazio-temporale la cui uscita è stata murata, da sempre e per sempre.
© Enzo Campi (dicembre 2020- gennaio 2021)